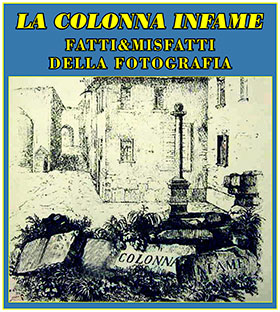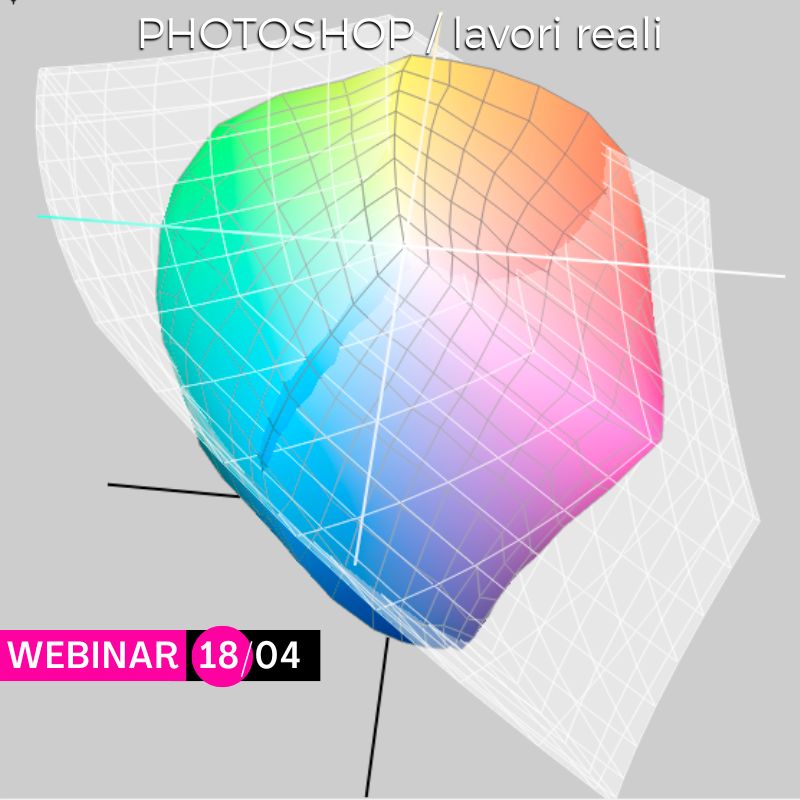Robert Capa è il simbolo del reportage. Quello duro, quello che il fotografo è lì per testimoniare. Cavaliere solitario dell’informazione. Demiurgo della notizia.
Il 27 novembre del 1932 era a Copenhagen per un comizio di Trotsky; nel settembre del ’36 sul fronte di Cordova, dove riprese il Miliziano; nel ’38 in Cina a coprire un’altra guerra; nel ’43 a seguire lo sbarco degli USA in Sicilia; il 6 giugno del ’44 a Omaha Beach a documentare il Giorno più Lungo; nel ’50 ad Haifa, nei campi profughi degli ebrei. Il 25 maggio del 1954 saltò su una mina, sulla strada da Namdinh a Thaibinh, in Indocina.

All’epoca i fotografi erano gli occhi di tutti noi gente comune. Aspettavamo l’uscita dei giornali per guardare gli avvenimenti accaduti nel mondo. Ed era gara tra i giornali per dare, primi, la notizia. Primi significava, se tutto andava bene, il giorno dopo l’accaduto per i quotidiani, una settimana per i settimanali.
Pochi minuti dopo il crollo del ponte di Genova in rete c’erano già i video di chi ne era stato testimone, girati addirittura dai primi soccorritori. Immagini confuse, mosse e tremolanti ma testimonianza immediata. Quella che abbiamo sempre cercato, anche se non lo sapevamo.
Le foto di Omaha Beach sono mosse e sfocate come quelle scattate dai telefonini di Genova. I mezzi dell’epoca non consentivano di più. Solamente dopo è stata attribuita loro una valenza estetica. Ma il loro scopo non era essere appese in una mostra; pubblicate nelle pagine di un libro.
Capa, reporter per antonomasia, è morto. Ucciso non da una mina tra le risaie del lontano oriente, ma da un killer che abbiamo in tasca.